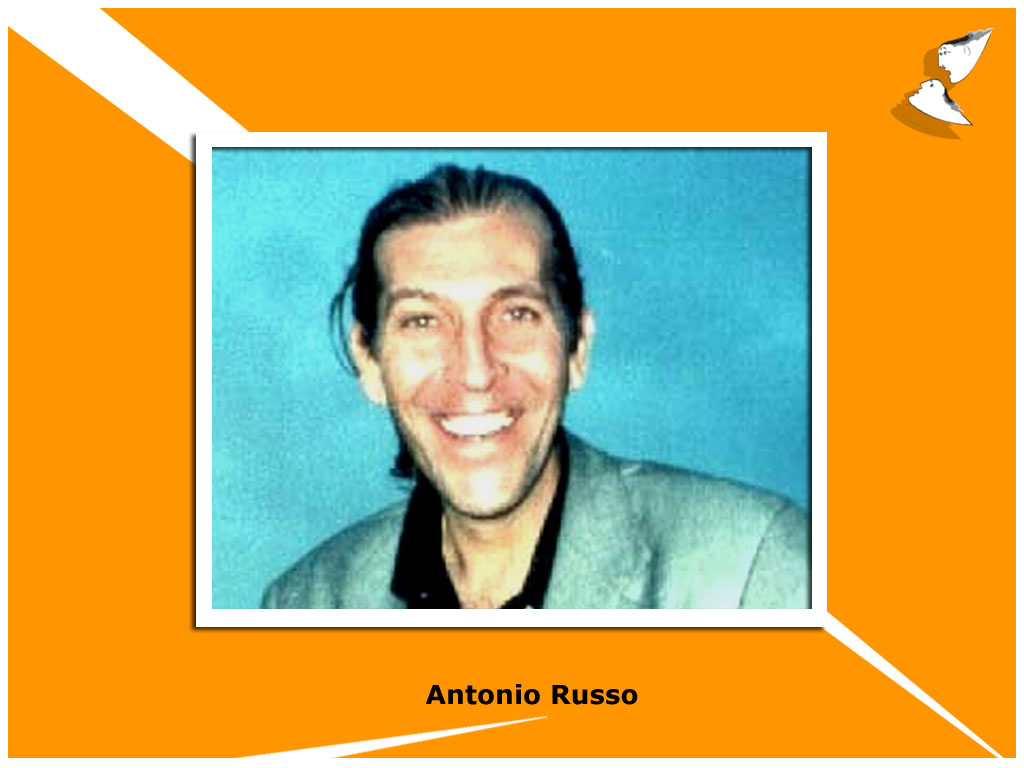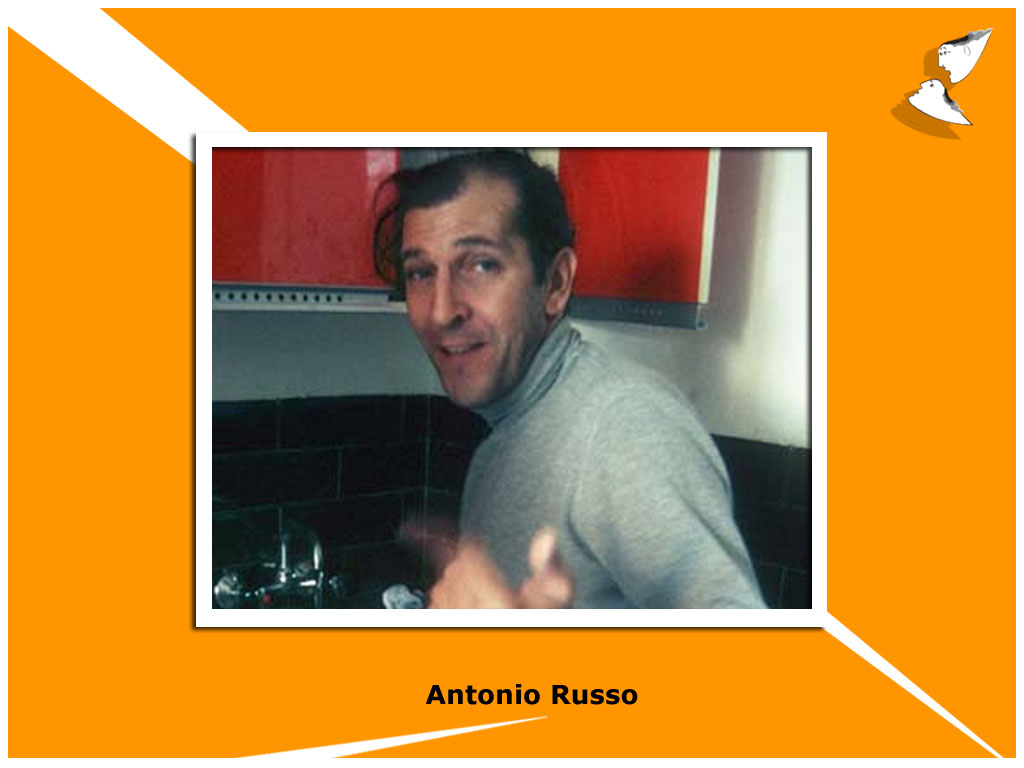Antonio Russo è nato a Chieti il 3 giugno 1960. Qui ha trascorso i suoi primi anni in orfanotrofio fino all’età di due anni, e poi alla Pineta di Pescara. Di quest’ultimo istituto, gestito da suore francescane, Antonio ha sempre conservato un ricordo carissimo, relativo soprattutto a Suor Fulvia, la suora alla quale era affidato. Da bambino spesso ne parlava e sempre con affetto. All’età di cinque anni è stato adottato e si è trasferito, con la madre adottiva, prima a Ravenna, dove ha frequentato le scuole fino alla terza elementare, e poi a Roma dove ha continuato gli studi nelle scuole elementari, medie e poi al liceo scientifico “Cannizzaro” dell’EUR. L’infanzia e l’adolescenza, per Antonio, privo di una famiglia normale, non sono stati né felici né facili.
Era un bambino desideroso di affetto, di ricevere e dare affetto, molto buono, generoso, ma irrequieto, sempre in cerca di nuove esperienze. I suoi insegnanti lo hanno sempre giudicato un alunno molto intelligente, curioso, desideroso di conoscere (già da piccolo leggeva moltissimo), ma insofferente di qualsiasi regola. Comunque i suoi studi sono sempre andati avanti regolarmente e negli anni del liceo con profitto notevole in alcune materie (filosofia, storia, letteratura). Riusciva molto bene nello sport. Da ragazzo ha vinto parecchie gare di nuoto e giocava con successo come portiere in una squadra di hockey su prato gestita dal CONI. Più grande, durante gli anni del liceo, ha frequentato una palestra di arti marziali ed era cintura marrone di karate.
Dall’età di 15 o 16 anni, durante le vacanze estive, a Tagliacozzo, in Abruzzo, lavorava in un allevamento di cavalli. Questa attività, svolta per il suo divertimento e per il compenso di qualche passeggiata a cavallo, oltre a fargli conoscere un lavoro molto faticoso, ma che a lui piaceva e che rappresentava uno sfogo all’irrequietezza del suo carattere, lo ha messo in contatto con persone e con ambienti diversi da quelli che frequentava abitualmente. Con molte di loro è nata un’amicizia che si è mantenuta anche nell’età adulta. Il proprietario dell’allevamento, un contadino semplice, ma di grande esperienza e di grandissima generosità d’animo, padre di quattro figli, ha finito con l’assumere per Antonio, in una età particolarmente difficile, il ruolo di quella figura paterna che, forse senza rendersene conto, Antonio aveva sempre cercato. E questo rapporto di affetto e di fiducia reciproca è durato anche dopo la fine dei rapporti lavorativi: è durato fino alla fine. Ed è in questo periodo che il suo carattere è cambiato, o, piuttosto, si è manifestato più chiaramente. Durante tutto il tempo della malattia, molto lunga e dolorosa, della nonna, che gli voleva molto bene, Antonio ancora giovanissimo (frequentava il liceo) ha aiutato in ogni modo ad assisterla, le è stato sempre vicino, ha saputo dimostrarle in ogni istante il suo affetto con un’abnegazione a volte commovente. Forse una trasformazione, in un certo periodo della vita, si produce in tutti, ma in lui è stata particolarmente evidente sia considerando le sue caratteristiche precedenti di imprudenza e irrequietezza, sia considerando la capacità di comprensione, la dolcezza, la generosità e la straordinaria sensibilità di cui Antonio adulto ha sempre dato prova.
Dopo la maturità scientifica si è iscritto alla facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa. Presto ha lasciato questo tipo di studi, scelto per l’interesse che provava per gli animali, che non lo attirava dal punto di vista scientifico. Si è iscritto alla facoltà di filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, dedicandosi allo studio che, fin dagli anni del liceo, era stato il suo interesse maggiore. In questo periodo, con un gruppo di studenti, ha fondato la rivista Philosophenia, alla quale ha dedicato per molti anni gran parte del suo impegno intellettuale approfondendo le tematiche legate alla filosofia del linguaggio e alla filosofia della scienza. Da editore autogestito e autoprodotto ha pubblicato alcuni volumi: “Nessuno è perfetto” a cura di Simonetta Massaroni, “Lineamenti di una teoria dell’etnocidio” del filosofo Rodolfo Calpini e “La storia infinita” raccolta di profili storiografici a cura di Vito Gironda.
Nell’87- 88 ha prestato il servizio militare di leva come aviere nell’aeroporto militare di Viterbo. Il servizio militare è stato iniziato molto malvolentieri, dopo essere stato rimandato il più possibile perchè considerato una perdita di tempo, oltre che una cosa altamente sgradevole. Invece, Antonio ha finito col trovarsi benissimo. Il giorno del Giuramento, l’intensità della sua emozione è stata sorprendente. Non c’è dubbio che in quel giuramento di fedeltà abbia impegnato veramente tutto se stesso. Comunque le armi e la vita militare non erano certo adatti a lui che non sopportava imposizioni. Fece amicizia con un sergente e lo aiutò a prepararsi a un concorso per l’insegnamento elementare. Dopo il congedo questa amicizia è continuata, e a Roma ha aiutato il fratello dello stesso sergente a prepararsi per un concorso alle dogane. Per il resto, la vita militare non ha lasciato traccia su di lui: non ne aveva ricordi notevoli e non ne parlava mai.
Era interessato invece a ogni problema di carattere filosofico e sociale e, in generale ad ogni tipo di conoscenza. Non ha mai avuto (né mai desiderato o chiesto) motorini o macchine, non ha mai preso la patente di giuda. Una volta (aveva circa dieci anni), durante un viaggio da Roma a Francavilla (eravamo soli e guidavo io), all’improvviso mi disse: “Io non guiderò mai. Non mi piace guidare”. E così è stato. Tutti i soldi (pochi) di cui disponeva erano spesi in libri, giornali, riviste. I libri costituivano per lui una tentazione alla quale non sapeva resistere. Ne comprava ogni giorno e infatti mise insieme una biblioteca di centinaia di volumi, di filosofia, soprattutto, ma anche di altri argomenti. L’altra sua grande passione, oltre alla lettura, era la musica. Aveva anche seguito, per alcuni anni, dei corsi di chitarra classica senza riuscire, con suo grande dispiacere, a diventare un buon musicista. Amava ogni tipo di musica, sopratutto quella classica che conosceva molto bene e di cui era un finissimo intenditore: la ascoltava continuamente anche mentre studiava o leggeva. Diceva che lo aiutava a concentrarsi. Gli piaceva molto anche ballare ed era un ballerino agilissimo, sempre il primo a partecipare alle feste di amici o ad altri divertimenti.
Dai primi degli anni ’90 ha preso parte attivamente alla militanza politica nella Gioventù Federalista Europea e datiamo da allora i suoi primi viaggi in Croazia e nella ex Iugoslavia. Qui, la sua prima visita a un campo profughi e la conoscenza, per la prima volta, di gente che la guerra aveva privato della casa, degli amici, di tutto, produsse in lui un’impressione grandissima. Era il mese di gennaio e faceva molto freddo, Antonio tornò a Roma soltanto con la camicia e una leggera maglietta. Ha avuto inizio allora la sua attività giornalistica. Ha scritto articoli per i “Comuni d’Europa”, ha lavorato a Roma per una radio locale e infine ha iniziato il suo lavoro per Radio Radicale. Uno dei primi servizi fu dalla Siberia, da Novosibirsk. Qui una notte fu preso a bastonate e derubato delle macchine fotografiche. Poi fu in Serbia, in Bosnia durante tutto il periodo della guerra. E ancora in Algeria, durante gli anni dei massacri integralisti, a Cipro, più volte in Ruanda per documentare la guerra tra hutu e tutsi e il dramma dei profughi, nel Congo. Pur lavorando molto e facendosi conoscere per i suoi reportage dalle zone più calde della terra non fu mai iscritto all’albo da lui ritenuto un’istituzione di natura burocratica ed impiegatizia. Ha fatto parte, invece, della Free Lance International Press come responsabile sindacale e poi, per qualche tempo, come vice presidente.
Questo tipo di lavoro coincideva con quelli che erano ormai anche i suoi interessi culturali: lo studio delle popolazioni, delle diverse culture, religioni, abitudini. Era affascinato da questo tipo di conoscenze: mi telefonava la sera da Paesi lontani e mi parlava per delle mezze ore, dell’arte orafa, del tipo di abitazione, del modo di vivere nei luoghi in cui si trovava. Mi parlava della musica, delle danze caratteristiche, delle feste tradizionali. In un primo tempo, quindi, questi viaggi hanno avuto per lui un interesse culturale oltre che giornalistico. Mentre continuava a trovarsi di fronte a numerose situazioni di guerra, povertà, sofferenza, l’interesse culturale ha lasciato il posto all’interesse umano. La conoscenza di uomini ridotti dalla guerra in condizioni disperate di miseria, di paura, di dolore lo ha completamente assorbito. Soprattutto i bambini erano sempre in fondo al suo cuore. Certamente Antonio ripensava alla sua infanzia, ai problemi, alla tristezza della prima parte della sua vita, all’emarginazione che anche lui aveva provato. Capiva le sofferenze degli altri proprio perchè anche lui aveva sofferto.
Durante le sue missioni non abitava mai in alberghi, ma in case private, presso famiglie modeste che affittavano un alloggio per necessità, mangiava insieme a loro, viveva la loro vita, era un amico. Così è stato in Bosnia, in Ruanda, dappertutto. Certo nei suoi reportage parlava delle situazioni militari e politiche per come si presentavano, in maniera oggettiva descriveva quello che succedeva e quello che si poteva presumere che potesse succedere. Ma ciò non toglie che il suo interesse, e il suo affetto fossero sempre per i deboli, per i perdenti.
Nel marzo del ’99 era nel Kosovo. A Pristina era già stato precedentemente, aveva già dato notizie sull’inasprirsi dei rapporti tra serbi e kosovari, aveva riportato in Italia fotografie raccapriccianti di cadaveri martoriati, fotografie che sono state consegnate al Tribunale dell’Aia.
Una scena lo aveva particolarmente colpito e ne parlava spesso per descrivere a che punto di atrocità si era arrivati: un vecchio kosovaro musulmano tirava a forza un bambino, suo nipote, per farlo avvicinare al cadavere del padre. Questo giaceva, con gli occhi sfondati, tra altri morti. Il bambino cercava di fuggire e piangeva, il nonno lo trascinava. E Antonio si chiedeva perchè: perchè il bambino salutasse il padre morto, o perchè odiasse per sempre chi lo avesse ucciso? Antonio considerava questa scena una delle più terribili tra le tante a cui aveva assistito. A Pristina alloggiava sempre presso una stessa famiglia con la quale aveva stretto rapporti di amicizia. Erano così affettuose queste relazioni che Antonio chiamava la sua padrona di casa “la mia mamma del Kosovo”. E insieme a questa famiglia ha vissuto le vicende tragiche della guerra. Quando i suoi padroni di casa sfollavano per evitare i bombardamenti, Antonio rimase in casa da solo, rifiutando di sottomettersi all’ordine di lasciare il Paese con tutti i giornalisti occidentali. Fu l’unico giornalista occidentale a restare a Pristina, l’unico testimone dell’Occidente di quanto stava accadendo nel Kosovo. Finché anche lui fu costretto ad allontanarsi per sfuggire al rastrellamento casa per casa operato dai serbi. Passò la frontiera con la Macedonia aiutato dai kosovari, sotto braccio ad una vecchia Rom. Dopo la guerra è tornato a Pristina dai suoi amici carissimi, amici come si può essere quando si sono divisi pericoli e sofferenze, quando si è vissuto insieme una tragedia. Ora questi amici sono miei amici.
E poi venne la Cecenia. Già all’inizio del 2000, Antonio era in Georgia, a Tblisi, per dare notizie sulla guerra tra russi e ceceni. In Cecenia, naturalmente, non si poteva entrare. Prese contatto con un gruppo di profughi ceceni e, con l’aiuto di questi, riuscì ad entrare non dai confini georgiani, ma attraverso altri Paesi confinanti. Ha potuto così rendersi conto personalmente delle distruzioni, dei massacri, delle devastazioni materiali e morali che erano in atto. Tornando in Georgia, con i profughi ceceni si sono stretti rapporti di amicizia e di fiducia. Per telefono mi parlava della situazione di questa gente, della loro miseria, della sofferenza e, a mano a mano, dal venir meno della speranza. I ceceni, dimenticati o ignorati da tutti, stavano scomparendo come individui e come popolo. E questo, secondo Antonio, non si doveva permettere. Ha cercato di dar loro aiuto. A sue spese (lui sempre a corto di soldi) ha fatto trasportare e curare all’ospedale di Tblisi un giovane gravemente ammalato. All’inizio dell’estate è tornato in Italia, ma con l’intenzione, me lo disse subito, di ripartire presto. Alla fine di luglio venne a Semproniano, dove allora io vivevo, e dove aveva moltissimi amici. In quei giorni, come ogni anno, nel paese si festeggiava il raccolto e si ripetevano i lavori della campagna, la mietitura, la trebbiatura, la raccolta della frutta, come si faceva una volta, con le stesse modalità, gli stessi attrezzi del passato. Antonio, come ogni anno, con grande piacere partecipava ai lavori con gli altri. Ma dopo due o tre giorni di permanenza, un pomeriggio tornò a casa e mi disse che la mattina seguente sarebbe partito per Roma con l’autobus delle cinque. Si sarebbe trattenuto a Roma il tempo necessario per i visti e i documenti e poi sarebbe ripartito per la Georgia. Capii che c’era stata una telefonata che lo avvertiva di qualcosa, ma sarebbe stato inutile per me fare domande e perciò non ne feci. La mattina dopo ci salutammo: io gli raccomandai la prudenza e lui mi assicurò che sarebbe stato prudente.
A settembre, a Tblisi, ci fu un congresso internazionale per trattare dell’inquinamento in quella regione e Antonio riuscì a sostituire il rappresentante radicale Oliviero Du Puis. Nel congresso parlò a lungo, dettagliatamente, dell’inquinamento del territorio ceceno e dell’uso di armi chimiche da parte dei Russi. Dopo il suo intervento, un uomo (non identificato) si alzò e, parlando in russo, pronunciò minacce all’indirizzo di Antonio. Dopo qualche tempo, una mattina (erano circa le nove) ricevetti una telefonata: Antonio, sconvolto, chiamava da Tblisi, stava guardando una cassetta che aveva ricevuto (non ha detto da chi) con scene orribili in cui erano coinvolti bambini. Gridava: “Non si può immaginare! Non si può immaginare!”. Non potei fare altro che raccomandargli di mantenersi calmo. Più tardi (verso le 11), un’altra telefonata: Antonio piangeva come fosse anche lui un bambino e mi disse queste testuali parole (sono certa di ricordarle benissimo): “C’è un medico all’ospedale di Grosug che meriterebbe il premio Nobel per quello che sta facendo con i bambini fatti a pezzi”. Mi ha ripetuto la stessa frase più volte. Allora ho pensato che si trattasse di bambini fatti a pezzi dai bombardamenti o dalle mine. Ma certo poteva anche trattarsi di altro e l’accenno al premio Nobel essere soltanto un assurdo. Per qualche giorno Antonio non rispose più al telefono. Dopo due o tre giorni sembrava tornato normale, mi parlò a lungo dell’arte orafa georgiana. Gli domandai di quella cassetta, mi rispose in poche parole che l’aveva data a tradurre.
Il 16 o il 17 ottobre sarebbe tornato a Roma. Il giorno 16, alle due del pomeriggio, mi telefonarono da Radio Radicale che era stato ritrovato il suo corpo. Naturalmente la cassetta non fu mai ritrovata e non furono ritrovati il computer, le macchine fotografiche, il satellitare. Nessun appunto, niente che riguardasse il suo lavoro. Andai a Tblisi con alcuni rappresentanti del partito radicale, incontrai i suoi amici, alcuni rappresentanti del partito radicale e alcuni profughi Ceceni. Questi mi ringraziarono per quanto Antonio avesse fatto, anche parlando al congresso dell’inquinamento del loro territorio, e uno di loro (un giovane) mi disse: “Noi non lo dimenticheremo. Antonio è un eroe per il nostro popolo.” Un piccolo popolo che va scomparendo, di cui nessuno si interessa, di cui forse presto si perderà la memoria, ma ci vuole certamente più coraggio a combattere da eroe in una guerra perduta che in una guerra vinta.
In una delle ultime telefonate, gli dissi di avere trovato in un negozio di antiquariato un bellissimo crocifisso e che lo avrei comprato per regalarglielo al suo ritorno. Mi rispose: “Lascia stare. Il crocifisso si porta nel cuore”. Rimasi sorpresa. Antonio non era mai stato religioso o, per lo meno, non aveva mai mostrato la sua religiosità: la sua prima comunione è stata probabilmente anche l’ultima. Ma in seguito, riflettendo, ho capito. Si può credere in alcune cose, si crede oppure no, ma credere non vuol dire sapere. Una cosa invece sappiamo con certezza: sulla Croce c’era un uomo, un uomo che era stato deriso, torturato e infine crocifisso. Al di là di ogni altra implicazione, è l’uomo crocifisso che Antonio portava nel cuore.
Ed è così che vorrei che fosse ricordato.
La madre,
Beatrice Russo